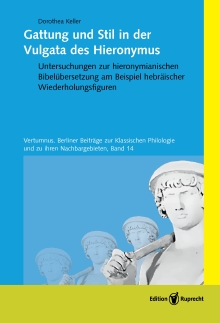Rezension
Annali di Storia dell'Esegesi 40/2 2023
La monografia di Dorothea Keller affronta una questione di nodale importanza nel panorama degli studi geronimiani: la tecnica di traduzione della Vulgata. La tesi sostenuta dalla studiosa è originale e offre una prospettiva nuova nel dibattito critico. Se, infatti, di sovente la critica cerca di rintracciare un unico indirizzo di traduzione comune a tutta l’opera, oppure opta per un’evoluzione nel tempo della tecnica di traduzione, la Keller sostiene che il metodo di traduzione dipende esclusivamente dal genere del testo con cui Girolamo si confronta. Originale è anche la metodologia con cui l’autrice sostiene le proprie argomentazioni, in quanto verte sull’analisi della resa in latino delle forme di ripetizione del testo ebraico.
Il libro si divide in dieci capitoli. Dopo una breve introduzione (cap. 1), un’intera sezione è dedicata allo status quaestionis (cap. 2). Attraverso un puntuale excursus che efficacemente riassume le diverse posizioni degli studiosi e le problematiche relative a questo tipo di ricerca, la Keller afferma che si è ben lungi dal raggiungere una soluzione comune e che è necessario un diverso approccio.
Il terzo capitolo è finalizzato a collocare la Vulgata all’interno della storia della traduzione, in particolare in relazione a quattro dimensioni culturali: la dimensione romano-pagana, la tradizione biblica in lingua latina, la tradizione dei padri della Chiesa di lingua greca e le condizioni pragmatiche alla base della traduzione di Gerolamo. Relativamente al mondo romano (par. 3.1), l’analisi si concentra su Cicerone e, in particolare, si mette in luce come i concetti di »verbum« e »sensus«, centrali nella teoria della traduzione geronimiana, siano stati ereditati dall’Arpinate, ma con significato mutato. Infatti, nella letteratura classica e in Cicerone la traduzione è concepita come »imitatio-aemulatio« e non è possibile parlare di opposizione tra traduzione libera e letterale. Dopo l’analisi di altri concetti fondamentali nella teoria della traduzione geronimiana (e.g. »propietas«, »euphonia«, »cacozelia«, »consuetudo«, »ambiguitas«), la Vulgata è messa in relazione con le traduzioni latine della Bibbia (par. 3.2) e in questo contesto è esaminata l’evoluzione di Gerolamo da semplice revisore, che analizza e sceglie tra le diverse varianti del testo greco, a traduttore, che prende le distanze dalla stessa LXX in favore dell’»hebraica veritas«. Nel contesto delle traduzioni latine è di-scusso anche il concetto di »latino cristiano«, le cui caratteristiche peculiari derivano dal fatto che è una lingua di traduzione. Nella sezione successiva (par. 3.3), l’autrice si sofferma sulla tradizione patristica greca e in particolare sull’influenza di Origene, a cui Gerolamo deve, tra le altre cose, la passione per l’ebraico, il rigore filologico e i due »sensi« delle Scritture, e di Eusebio, suo modello per quanto riguarda le opere compilative concepite come ausili per le Scritture. In seguito, la Keller affronta un’altra questione cruciale, ossia gli obiettivi e le finalità dell’opera (par. 3.4). Dopo aver esplorato la possibilità dello scopo liturgico, si concentra sulla tesi secondo cui la Vulgata sia stata concepita come opera destinata alla lettura e allo studio privato.
Con la successiva sezione si apre la parte dedicata all’analisi della tecnica di traduzione. Nel capitolo dedicato all’esplicazione della metodologia (cap. 4), la Keller spiega di voler indagare la resa nella Vulgata delle cosiddette »Wiederholungsstrukturen« (»strutture di ripetizione«), ossia scelte espressive come la »geminatio«, l’anadiplosi, la palindromia, l’anafora, la ripetizione di termini tecnici e di espressioni formulari, poliptoti, figure etimologiche e le reiterazioni dovute all’impossibilità per l’ebraico di introdurre costruzioni zeugmatiche. Dal momento che tali ripetizioni sono caratteristiche linguistiche molto comuni in ebraico ma non frequenti in latino, dall’analisi della resa di tali ripetizioni in un determinato passo si può comprendere se la tecnica di traduzione adottata sia libera o letterale e se essa sia influenzata dal genere del passo esaminato. Dopo aver dimostrato che Gerolamo ha la percezione del concetto di genere testuale (par. 4.2), la studiosa illustra la scelta dei passi analizzati nei capitoli successivi. I passi scelti sono tratti dai libri di Isaia, Genesi e Rut: si tratta, infatti, di libri tradotti dall’ebraico in un ampio arco cronologico, che sono caratterizzati da grande varietà stilistica e per i quali è disponibile l’edizione critica delle antiche traduzioni latine a opera del Vetus latina Institut Beuron. Di questi tre libri sono analizzati intenzionalmente dei passi con caratteristiche molto diverse (e.g. testi lirici, cataloghi, narrazioni in prosa), al fine di poter stabilire una correlazione tra genere testuale e tecnica di traduzione adottata. L’analisi dei passi scelti è molto precisa e dettagliata e comprende riflessioni e osservazioni sull’ordine delle parole, sulla morfologia, sulla sintassi e sulle scelte lessicali. Apprezzabile è anche il puntuale confronto della resa delle Vulgata con la LXX e, dove disponibile, con il testo della Vetus latina, così come la tavola sinottica di comparazione tra i testi che è posta a conclusione di ogni capitolo.
Il primo passo analizzato è il capitolo 7 del libro di Isaia (par. 5.1), in cui è narrato il primo intervento del profeta e la profezia della nascita verginale. I versetti sono caratterizzati nella Vulgata da una resa molto letterale sia nelle scelte lessicali sia nella sintassi. Laddove vi siano delle variazioni, non sembrano motivate dall’intenzione di ricercare il »buon« latino classicista. Segue poi l’analisi di Is 45,1–8 (par. 5.2), testo lirico caratterizzato da molti parallelismi nella costruzione sintattica. Anche in questo caso, la Vulgata riproduce fedelmente l’andamento paratattico della sintassi e, relativamente alle scelte lessicali, laddove uno stesso lessema ricorra nel testo ebraico, è tradotto con la medesima parola latina.
Lo studio si concentra poi sul libro della Genesi (cap. 6), di cui sono selezionati tre passi. Il primo è la cosiddetta »genealogia di Adamo« (Gen 5), in cui la formula fissa ebraica relativa al susseguirsi delle generazioni è riprodotta letteralmente nella Vulgata senza particolari variazioni, se non a livello dei connettori. Interessante è poi anche la resa di Gen 22,1–19, l’episodio del sacrificio di Isacco. Nel testo ebraico vi sono ben sette sintagmi che si ripetono in modo simile o identico e sono riprodotti fedelmente nella Vulgata. Gerolamo, infatti, dimostra coerenza nella resa di specifiche parole e dei principali campi semantici. Le variazioni avvengono soltanto a livello sintattico mediante il ricorso all’ipotassi. Un simile approccio è ravvisabile anche nella traduzione della storia di Giuseppe, di cui sono analizzati in particolare i versetti 39,3–6 e 49,22–26.
Nel settimo capitolo l’indagine verte sul libro di Rut, del quale è analizzata la sezione introduttiva (1,1–5), la promessa di Rut alla suocera (1,16), l’etimologia del nome Noemi (1,20), il dialogo in 2,19–3,1, le benedizioni e le preghiere conclusive (4,11–15), il catalogo genealogico (4,18–22) e la resa di alcune radici significative. Com’è evidente, anche in questo caso sono presi in esame passaggi molto differenti tra loro al fine di dimostrare che, in uno stesso libro, Gerolamo ricorre a tecniche di traduzioni diverse a seconda del contenuto del passo. Infatti, in un contesto di narrazione storica la resa è più letterale (cf. l’introduzione e il catalogo), mentre altrove le variazioni intervengono sia a livello lessicale sia sintattico (e.g. nel caso della promessa di Rut, in cui si evidenziano variazioni sintattiche e aggiunte patetiche, o nella resa del dialogo, in cui le introduzioni ai discorsi, ripetitive e schematiche in ebraico, sono caratterizzate in latino da variazioni lessicali e sintattiche e al contempo alleggerite mediante il ricorso a pronomi o all’ »oratio obliqua«, l’assenza di ripetizioni e il cambiamento nella diatesi). A livello lessicale, interessante è la resa del verbo ????, che è tradotto diversamente a seconda che sia riferito a Noemi e dunque indichi un effettivo ritorno alla sua terra d’origine, o a Rut, per la quale designa uno spostamento in una terra straniera. Inoltre, è indagata la resa di ???? nel capitolo 3, tradotto intenzionalmente talvolta con »sdraiarsi« e talvolta con »dormire«. Particolarmente rilevante è, infine, la resa di ???, in quanto emerge che Gerolamo, attraverso scelte lessicali e sintattiche, ricalca l’uso del linguaggio giuridico quasi a presentare Boas come un retore classico.
Nella sezione successiva (cap. 8) sono analizzati alcuni poliptoti dei quali Gerolamo fornisce un commento nelle sue opere (»occidenti occidentis«; »civitates civitatum« – »ornatus ornamentorum«; »saecula saeculorum« – »caeli caelorum«).
In conclusione (capp. 9 e 10), dallo studio emerge che, a differenza di quanto precedentemente avanzato dalla critica, la tecnica di traduzione di Gerolamo pare influenzata dal tipo di testo che Gerolamo sta traducendo. La prospettiva sembra dunque suggerire una soluzione altra nell’annosa questione relativa alla tecnica di traduzione della Vulgata: non è lecito tentare di individuare un’unica tecnica di traduzione per l’opera, né operare un’indagine libro per libro, ma è opportuno condurre un’analisi versetto per versetto, poiché all’interno di uno stesso libro si ravvisano generi diversi e dunque diverse tecniche di traduzione. Ciò restituisce unitarietà alla Vulgata, che dev’essere approcciata non come un insieme di libri distinti e caratterizzati da tecniche di traduzione differenti, ma come una Gesamtkunstwerk, ossia »un’opera d’arte totale«.
Giulia Leonardi